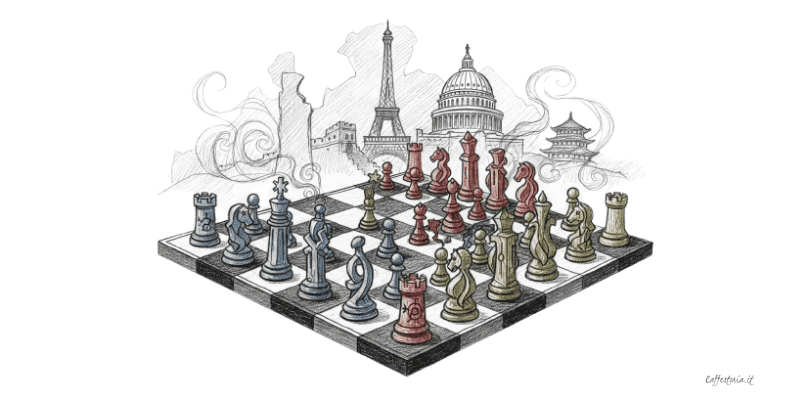Una donna politica, un primo ministro e tre cardinali. Come – e perché – nella nuova geografia della politica e dell’economia la morale rimane una coordinata imprescindibile. Insieme alla vita.
Tutto torna. È curioso che il termine geopolitica, così di moda negli ultimi anni, sia stato utilizzato per la prima volta da un nordeuropeo, Rudolf Kjellén, geografo e uomo politico svedese. Era il 1899 e sembra che l’intenzione di Kjellén fosse quella di mettere in evidenza la peculiare natura di «organismo vivente» dello Stato, strettamente connessa alla geografia. Tornerà a farlo a prima guerra mondiale iniziata, con la geopolitica divenuta supporto e giustificazione alla competizione per il potere, nell’affermazione di identità e interessi spesso divergenti, fossero questi svedesi, britannici o tedeschi. Per non parlare di quelli statunitensi e sovietici nel mondo bipolare del secondo dopoguerra.
Proprio il Nord Europa torna oggi al centro della geopolitica. Grønland, “terra verde”, che qualcuno vorrebbe ridipinta a stelle e strisce. Le mire di Donald Trump sulle risorse materiali e immateriali della Groenlandia (ne parlavo, in tempi ancora non sospetti, qui nel marzo 2025) rappresentano un sintomo distintivo del sopravvento patologico del lunatismo sulla politica e in alcuni suoi rappresentanti.
Nel tempo del disordine ordinato al profitto, il risveglio da illusioni che sono durate troppo a lungo è soltanto un’altra fase dell’incubo. Sarebbe facile citare la massima goyana secondo cui il sonno della ragione genera mostri: la verità è che per gli insonni del sueño de la razón è il momento di incontrare i monstruos. Ma c’è chi prova ad illuminare le crepe del presente, aprendo spiragli per immaginare e costruire qualcosa di nuovo.
Serve anzitutto tracciare una morfologia di questo nostro tempo geografico. Siamo sul limitare della «rottura dell’ordine mondiale, della fine di una bella storia e dell’inizio di una realtà brutale in cui la geopolitica tra le grandi potenze non è soggetta ad alcun vincolo». È questa la tesi espressa al World Economic Forum a Davos dal primo ministro canadese Mark Carney, già governatore della Banca d’Inghilterra e della Banca del Canada, oltre che successore di Mario Draghi alla presidenza del Financial Stability Board (qui il video e qui la trascrizione integrale in italiano).
C’è chi aveva già evidenziato il nostro vivere non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca. «Siamo nel mezzo di una rottura, non di una transizione», prosegue Carney. «Negli ultimi due decenni una serie di crisi – finanziarie, sanitarie, energetiche e geopolitiche – ha messo a nudo i rischi di un’integrazione globale estrema». Con risultati prevedibili. «Quando le regole non ti proteggono più, devi proteggerti da solo. Ma guardiamo con lucidità a dove questo conduce. Un mondo di fortezze sarà più povero, più fragile e meno sostenibile. E c’è un’altra verità: se le grandi potenze abbandonano persino la pretesa di regole e valori per perseguire senza ostacoli il proprio potere e i propri interessi, i benefici del “transazionalismo” diventano più difficili da replicare. Le potenze egemoni non possono monetizzare indefinitamente le loro relazioni».
In effetti, la pretesa che ogni azione, relazione e forma di vita possa essere valutata, misurata o giustificata solo in base al suo presunto valore finanziario sembra il nuovo orientamento dominante. Forse è per questo che Tillie Martinussen, politica groenlandese, si sente in dovere di precisare in un’intervista (qui il video) alcuni tratti del popolo che da millenni abita l’isola del contendere. «Non vogliamo essere ricchi come gli americani. Guardate quanto sono avidi. Arrivano persino a sparare ai loro amici o invadere i loro amici per avidità. Sappiamo che ci sono minerali e forse petrolio nel nostro sottosuolo, e questo vale molto più di qualsiasi offerta. Ma anche se non avessimo nulla, non ci faremmo comprare». L’analisi di Martinussen – certo tutt’altro che applicabile ai soli Stati Uniti dell’amministrazione Trump – può sembrare hippie, ma è invero lucida e disincantata. «Sembra tutto folle e fuori controllo. Sembra che [Trump] voglia solo accontentare alcuni suoi ricchi sostenitori per poter correre per un terzo mandato».
Finora, i primi vagiti del nuovo multipolarismo – o, se volete, l’agonia del morente unipolarismo a guida statunitense – hanno comprensibilmente destato più di qualche preoccupazione. «Gli eventi in Venezuela, Ucraina e Groenlandia hanno sollevato interrogativi fondamentali sull’uso della forza militare e sul significato della pace», sottolineano in una dichiarazione congiunta sulla visione morale della politica estera americana (qui il testo in inglese) tre cardinali statunitensi, Blase J. Cupich, arcivescovo di Chicago, Robert W. McElroy, arcivescovo di Washington, e Joseph W. Tobin, arcivescovo di Newark. «I diritti sovrani delle nazioni all’autodeterminazione appaiono estremamente fragili in un mondo di conflitti sempre più vasti. L’equilibrio tra interesse nazionale e bene comune viene inquadrato in termini fortemente polarizzati».
Tratteggiati rilievi e voragini della geografia politica del nostro tempo, domandiamoci: come possiamo abitarla? In questo senso, la posizione del canadese Carney è pragmatica: «Affrontiamo attivamente il mondo per quello che è, non aspettiamo un mondo che vorremmo fosse». È indubbio che la prevaricazione internazionale e intranazionale stia assumendo connotati patologici. Da un lato, perciò, identificare e stigmatizzare i fattori di destabilizzazione è ineludibile. «È un po’ come quando hai una muta di cani da slitta: se uno dei cani all’improvviso si gira e ti morde, devi toglierlo dal gruppo, portarlo fuori e sparargli. Ovviamente non spareremo agli americani, siamo un popolo pacifico. Ma non puoi più fidarti di quel cane», osserva con eccesso metaforico Martinussen. D’altro canto, è necessario un impegno personale e collettivo. «Leggiamo, siamo istruiti e conosciamo le notizie del mondo», prosegue Martinussen. «Saremo qui ancora tra centinaia di anni dopo Donald Trump».
«Abbiamo la popolazione più istruita al mondo… Abbiamo capitale, talento,… la consapevolezza di ciò che sta accadendo e la determinazione ad agire di conseguenza», le fa eco Carney. «Sappiamo che questa rottura richiede più di un adattamento: richiede onestà sul mondo per quello che è… Il vecchio ordine non tornerà. Non dovremmo rimpiangerlo. La nostalgia non è una strategia. Ma dalla frattura possiamo costruire qualcosa di migliore, più forte e più giusto». Qualcosa che non sia fondato sull’isolamento, ma su una collaborazione realistica e per obiettivi comuni. «Il costo dell’autonomia strategica, della sovranità, può anche essere condiviso. Gli investimenti collettivi nella resilienza sono meno onerosi che costruire ciascuno la propria fortezza. Standard condivisi riducono la frammentazione. Le complementarità generano benefici a somma positiva». E, insieme, un’autocoscienza che abbia il coraggio di andare finalmente oltre la passività della menzogna. «I potenti hanno il loro potere. Ma anche noi abbiamo qualcosa: la capacità di smettere di fingere, di nominare la realtà, di costruire forza in patria e di agire insieme».
Sarà imprescindibile farlo, però, orientando l’azione e il fine secondo «un livello molto più alto» della sola sicurezza. «L’instaurazione di una politica estera autenticamente morale», la chiamano Cupich, McElroy e Tobin. «Cerchiamo di costruire una pace veramente giusta e duratura, quella pace che Gesù ha proclamato nel Vangelo. Rinunciamo alla guerra come strumento di interessi nazionali ristretti e affermiamo che l’azione militare deve essere considerata solo come ultima risorsa in situazioni estreme, non come un normale strumento della politica nazionale. Cerchiamo una politica estera che rispetti e promuova il diritto alla vita umana, la libertà religiosa e l’accrescimento della dignità umana in tutto il mondo».
Non è che l’inizio, ma non è poco. Forse non si tratta dei paradigmi della nuova geografia mondiale, ma potrebbero essere le buone pratiche di una interazione su basi nuove. «Papa Leone ribadisce inoltre l’insegnamento cattolico secondo cui “la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento indispensabile di ogni altro diritto umano”, e che aborto ed eutanasia distruggono tale diritto. Egli richiama la necessità di aiuti internazionali per salvaguardare gli elementi più centrali della dignità umana, oggi sotto attacco». È su queste fondamenta che si consumerà nei prossimi anni l’autentico scontro di civiltà.
«A qualunque costo bisogna smettere di armare il mondo per distruggerlo», scrive nell’agosto 1977 a Giulio Andreotti il “sindaco santo” di Firenze, Giorgio La Pira (Augusto D’Angelo, «Bisogna smettere di armare il mondo». Giulio Andreotti-Giorgio La Pira. Carteggio (1950-1977), Polistampa, 2023). Che tutto è vita, dalla persona all’organismo vivente dello Stato, La Pira lo affermerà un mese dopo, in un telegramma indirizzato al presidente del Consiglio di un governo detto “di solidarietà nazionale”: «Imminenza discussione Senato legge sullo aborto. Ti ricordo ancora una volta che non può non esserci responsabilità di governo e non devi a qualunque costo permetterla». Un nuovo stile di abitare il mondo passerà anche da quanta vita – e non da quanto denaro – avremo il coraggio di farci entrare.
© Vuoi riprodurre integralmente un articolo? Scrivimi.
Sostieni Caffestoria.it