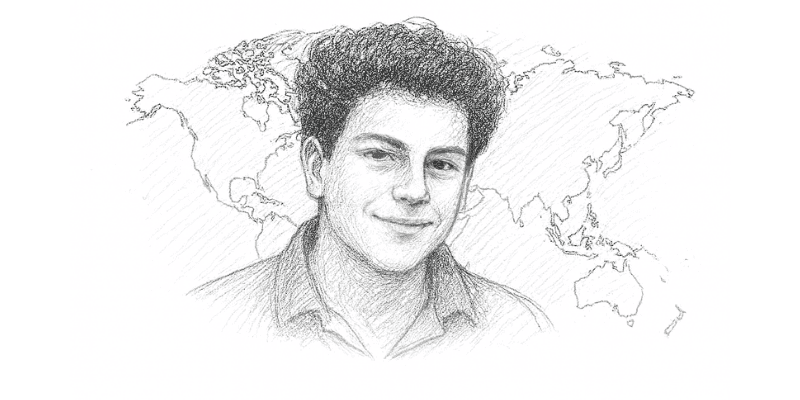Storie di giovani santi, giubilei e migranti.
«Come ho detto anche al Rev.mo Mons. Viganò, sto riposando qui alle falde del Vesuvio, e mi sento benissimo. Il 23 [giugno]sarò a Roma, per assistere, il 25, alla santificazione della Beata Goretti. Mi son permesso, perciò, incomodare Mons. Viganò, che è la bontà personificata, perché, se sia possibile, mi procuri un biglietto d’ingresso che mi faccia assistere un poco più davvicino alla cerimonia». A scrivere, il 6 giugno 1950, è padre Nicola Miranda, missionario fra gli emigrati italiani e vicario di Santa Adélia, nello Stato di San Paolo, Brasile.
Sullo stesso versante dell’Atlantico, ma svariati gradi più a nord, la santità di Maria Goretti – insieme al Giubileo del1950 – attrae anche don Riccardo Pasquale Mugnano, parroco fra gli italiani nella chiesa di Saint Mary of Mount Virgina New Brunswick, New Jersey, Stati Uniti. «Solo dovrebbe Lei farmi il favore informarmi cosa bisogna fare per ottenere il permesso d’essere [a San Pietro] per la canonizzazione della Beata Maria Goretti e se è possibile avere qualche posto riservato per il mio gruppo di 34 persone. Arriveremo a Roma la sera del 7 giugno». Le lettere conservate nell’archivio storico della Fondazione Migrantes custodiscono la memoria di esperienze religiose intessute di mobilità umana.
La profezia della santità giovanile e i giubilei
La Chiesa, nel corso della storia, ha riconosciuto nella santità giovanile un segno particolarmente profetico. Giovani sante e santi mettono in luce la capacità del cristianesimo di incarnarsi nelle diverse epoche storiche e di proporre modelli di vita che rispondono al tempo presente. L’Anno Santo che stiamo vivendo ci offre la testimonianza di Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, il primo morto a 24 anni nel 1925, il secondo a soli 15 anni nel 2006. È vero, come scrive Giovanni Paolo II nella bolla di indizione del Grande Giubileo del 2000, Incarnationis mysterium, che «una lunga storia di santità potrebbe essere descritta proprio a partire dalla pratica del Giubileo».
L’Anno Santo del 1950 celebra le virtù di Maria Teresa Goretti, uccisa a soli 11 anni nel 1902 per aver difeso la propria dignità e la propria fede. Un’Italia rurale di inizio Novecento, segnata da povertà, analfabetismo e forte radicamento contadino, che sembra lontana anni luce dalla Torino intellettuale e industriale di Frassati e dall’era a trazione digitale di Acutis. Eppure non mancano gli elementi in comune. A cominciare da due madri – Assunta Carlini e Antonia Salzano – che, separate da 75 anni, ma abbracciate dalla medesima folla in piazza San Pietro, sono ben consapevoli che la santità non è mai fuori dal tempo.
Tutt’altro: nel Giubileo del 1950, l’esempio di Maria Goretti unisce l’Italia, anche l’Italia dell’emigrazione. In verità, la stessa storia familiare dei Goretti è intessuta di mobilità bracciantile e contadina, dall’Anconetano all’Agro Pontino. Nel secondo dopoguerra, in un contesto storico segnato dalla ricostruzione post-bellica, Maria evidenzia la dimensione familiare e comunitaria della santità, come risposta a un mondo che sembra conoscere soprattutto l’eroismo della guerra, la violenza e la disgregazione sociale e morale.
Le trasformazioni sociali, e la mobilità umana che le accompagna, non sono estranee neppure alla Torino degli anni Venti, città industriale e crocevia di tensioni sociali e politiche. Pier Giorgio Frassati, giovane appartenente a una famiglia dell’élite intellettuale e politica, abita il capoluogo piemontese trasformandolo dall’interno, attraverso la pratica della solidarietà e della giustizia. La sua esperienza spirituale si radica nell’Azione cattolica e nelle opere di carità, ma nondimeno si esprime anche attraverso la passione per la montagna e la vita comunitaria.
Un modello di santità laicale capace di coniugare fede e impegno civile, che alla contestazione – sovente anticristiana – della modernità risponde non per sottrazione, ma per aggiunta: anzitutto di luce, di sale e di lievito in una Torino industriale che attira masse di lavoratori da altre regioni d’Italia, confrontandosi con le nuove periferie urbane ed esistenziali di un mondo andato fuori sincrono rispetto al respiro dell’uomo. Non è così dissimile, poco meno di un secolo dopo, l’esperienza di Carlo Acutis.
Nella nuova realtà globale e globalizza, sempre più interconnessa negli strumenti e sconnessa nell’essenza, Carlo incarna una santità transnazionale, resa universale dalle reti digitali. La sua “santità globale” – nato in Inghilterra, cresciuto in Italia, sepolto ad Assisi, venerato in tutto il mondo grazie al web – dimostra come la fede possa abitare i nuovi spazi della comunicazione digitale, che si esprime anche attraverso i linguaggi della contemporaneità, trasformando la tecnologia in veicolo di evangelizzazione.
In tempi che cambiano senza sosta, la gioventù si conferma interprete attenta del proprio tempo e abile lettrice dei segni che lo caratterizzano. Per questo la santità giovanile non è mai un ideale astratto, ma una categoria dinamica capace di assumere forme diverse.
Di più, le esperienze di Maria Goretti, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis mostrano come la santità non conosce confini: la fede si muove insieme alle persone, attraversa tempi, terre e culture, diventa patrimonio universale. In un’epoca di migrazioni e globalizzazione, la santità è in cammino, pellegrina tra i popoli, segno di un’umanità che cerca Dio al di là di ogni confine. L’umanità in movimento è chiamata a farsi interprete del proprio tempo.
Missionari di speranza
La santità è in cammino, come pure il rapporto fra Chiesa e mobilità umana nel tempo. L’analisi complessiva del percorso storico, pastorale e sociale dei Giubilei dalla metà del Novecento a oggi evidenzia un progressivo mutamento di paradigma. Le persone migranti chiedono e ottengono di essere riconosciute come protagoniste attive della società, spesso strutturate in comunità che partecipano sempre più pienamente anche alla vita della Chiesa.
È, questo, un elemento fondamentale di cui tenere conto: assistiamo al passaggio dalla coscienza di una “assenza”, causata dalla partenza, alla quale rispondere soltanto con un “ritorno” (Giubileo del 1950) a una “presenza” che desidera e deve essere riconosciuta come vitale nei luoghi del quotidiano (1975), nelle nostre città ancora da pacificare (1983-1984); ancora, la partecipazione sempre più piena delle persone migranti e delle altre categorie della mobilità umana alla vita della società e della Chiesa, anche sotto il profilo culturale e spirituale (2000), conduce al riconoscimento di un loro ruolo specifico, segno di contraddizione e strumento della misericordia (2016).
In altri termini, le persone migranti non sono né “assenti” né semplicemente “presenti”, bensì protagoniste vitali e responsabili della società e della Chiesa. Ha detto papa Leone nel corso dell’Udienza generale del 14 giugno 2025: «Anche oggi le comunità di migranti sono presenze che ravvivano la fede nei Paesi che le accolgono. Il Vangelo viene da fuori. […] Già questo è un segno di speranza, perché ci ricorda come i popoli si continuano ad arricchire a vicenda».
La mobilità umana, nelle sue diverse forme, è riconosciuta come un’espressione intima della condizione umana e della vita cristiana, con una propria missione e una responsabilità specifica nella Chiesa. Il Giubileo 2025 conferma e rilancia questo impegno, sottolineando il ruolo fondamentale della partecipazione attiva delle persone migranti nella Chiesa universale e nella società civile, come portatrici di elementi di criticità, ma anche aralde di una Chiesa conciliare in uscita e di «una Chiesa missionaria, che costruisce ponti» – come ha detto il Papa nella prima benedizione Urbi et Orbi, l’8 maggio 2025 – e che proclama la speranza.
È l’invito a un’accoglienza che non sia superficiale, ma piuttosto radicata nella cultura dell’incontro e nel dialogo interreligioso e interculturale. Ogni Giubileo rappresenta una opportunità preziosa per riflettere sui temi della giustizia, della solidarietà e dell’inclusione. L’attenzione a comunità e gruppi specifici, insieme a questioni strategiche della giustizia sociale e internazionale, testimoniano una Chiesa capace di un dialogo profondo con le questioni poste dall’umanità in movimento.
La speranza e la misericordia sono gli orizzonti di questa storia, che giunge al Giubileo del 2025 come momento di grazia e di rinnovato impegno. Per questo, sussiste il forte richiamo a non concepire l’Anno Santo come una “parentesi”, bensì come il momento condensato di un cammino continuo verso la fraternità e la santità.
Il ruolo storico e sociale dei Giubilei nella vita della Chiesa si intreccia con la dimensione personale e comunitaria del pellegrinaggio, che assume significati profondi anche sotto il profilo umano e sociale. La pastorale della mobilità si combina con le tematiche globali di sviluppo umano, diritto d’asilo, lotta contro l’inequità e per la giustizia. Il magistero sottolinea questa matura consapevolezza nell’impegno pastorale verso le persone migranti come soggetti con una vocazione e un messaggio specifici. La mobilità umana costituisce un segno dei tempi che interpella la Chiesa a incarnare sempre più in ogni realtà la fede vivificante, la speranza sociale e la carità attiva. In questo senso, i Giubilei costituiscono un’occasione privilegiata per tracciare percorsi di liberazione e di crescita umana, culturale e spirituale.
© Vuoi riprodurre integralmente un articolo? Scrivimi.