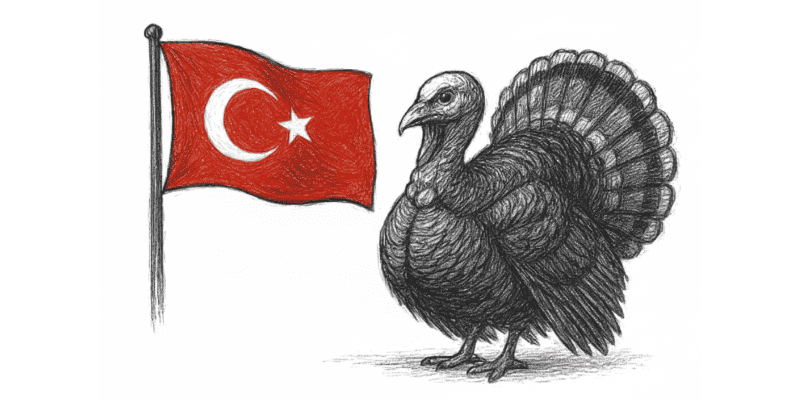Dettaglio curioso nella comunicazione del prossimo viaggio apostolico di papa Leone XIV in Turchia e Libano: per riferirsi al Paese di Ankara, viene adottata anche per l’italiano la denominazione Türkiye. Rispetto, correttezza formale o sana prudenza prima di un viaggio apostolico complesso?
Dite ancora “Turchia”? Male. Nel 2021 – anno del ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – il governo di Recep Tayyip Erdoğan ha indicato una nuova denominazione, Türkiye, a detta del presidente più adatta a «rappresentare ed esprimere al meglio la cultura, la civiltà e i valori della nazione turca». L’anno successivo, la Turchia – pardon, Türkiye – ha avanzato formale richiesta alle Nazioni Unite per il cambiamento della denominazione internazionale, da preferirsi in inglese e nel resto delle lingue.
Da qui, la ragione dell’uso di Türkiye anche da parte della Santa Sede in circostanze ufficiali e della comunicazione. Rispetto, correttezza formale o sana prudenza prima di un viaggio apostolico – il primo di papa Leone XIV – già indicato come delicato, se non complesso, in considerazione del panorama politico e religioso, dello status di minoranza dei cristiani e dello scisma storico con la Chiesa ortodossa? Qualcuno ha parlato di uno “stress test” dei legami interreligiosi.
Ma perché il cambio di nome? E soprattutto: cosa c’entrano, in tutto questo, i tacchini? Colpa degli inglesi, più che dei gallinacei.
Si tratta di una vecchia storia, o piuttosto di una storia vecchia. Il termine anglosassone per riferirsi alla Turchia, Turkey, è in uso almeno dalla seconda metà del ‘300 nei lavori di Geoffrey Chaucer, poeta e diplomatico inglese celebre per I racconti di Canterbury. Ma è dopo l’incontro fra gli europei e le popolazioni precolombiane dell’America che la vicenda assume tratti buffi, salvo che per i turchi. Con poca fantasia, il termine inglese turkey (o turkeyhen) è applicato al succulento meleagris gallopavo d’importazione, che in America sarà poi simbolo della tradizionale gratitudine, nell’errata convinzione che giungesse sulle tavole del Regno Unito dalla Turchia. La confusione nasceva dal fatto che i mercanti turchi importavano questo ed altri animali dal Nuovo Mondo, commercializzandoli anche in Inghilterra.
Fu così che il tacchino si vide chiamato “turco”, ma soprattutto che la Turchia si ritrovò detta “tacchino”. Una portata tanto più indigesta per le recenti aspirazioni di protagonismo geopolitico tutt’altro che “volatili” del presidente Recep Tayyip Erdoğan.
Türkiye è il nome, in lingua turca, adottato ufficialmente dal Paese dopo la fondazione della Repubblica di Turchia, nel 1923, ma poco praticato a livello internazionale. Il termine türk, che in turco antico rimanda alla forza, è attestato fin dall’VIII secolo in alcune iscrizioni nell’attuale Mongolia. Lo stesso Mustafa Kemal, fondatore e primo presidente della Repubblica turca, dal 1934 è detto Atatürk, “padre dei turchi” (e della Turchia).
I Bizantini, che bazzicarono per qualche secolo con alterni successi l’area dell’attuale Turchia (o Türkiye, come preferite), erano soliti definire turchi i popoli stabilitisi in Ungheria, e poi i Selgiuchidi dell’Anatolia. Dopo di loro, ci si riferiva all’Impero Ottomano già come a “turco”. Quanto all’italiano, la parola Turchia è pressoché invariata dalla sua derivazione latina medievale.
Dal canto suo, anche il Libano – che in lingua italiana mantiene invece la propria denominazione tradizionale anche in questo viaggio apostolico – ha una storia etimologica affascinante. Lebnan o Lebnèn in dialetto locale, Lubnān in arabo e Lebanon in inglese, deriverebbe dalle parole semitiche per “bianco” e “latte”, in riferimento alla candida cima innevata del Monte Libano. Citato 68 volte nella Bibbia (versione CEI 2008), gli sono dedicati versi splendidi.
Va detto che il dibattito sulla traduzione dei toponimi da una lingua all’altra – negli ultimi anni ci sono passati, solo per fare alcuni esempi, Iran, Thailandia, Sri Lanka e Macedonia del Nord – è recentemente tornato di attualità rispetto alle due forme traslitterate della capitale dell’Ucraina: Kyiv, secondo la versione ucraina, e Kiev in quella russofona (ancora predominante). In questo caso, la questione è carica di pesanti significati geopolitici circa l’indipendenza della nazione ucraina, che segnano la distanza rispetto a ciò che muove il governo di Ankara. Che anche per la Turchia (e per tutti noi) valgano i versi di Libano Sud del poeta egiziano Michel Cassir? «Agonia delle parole / prima diseredate e poi frantumate / come noccioli di olive / in una macina scura».
© Vuoi riprodurre integralmente un articolo? Scrivimi.
Sostieni Caffestoria.it