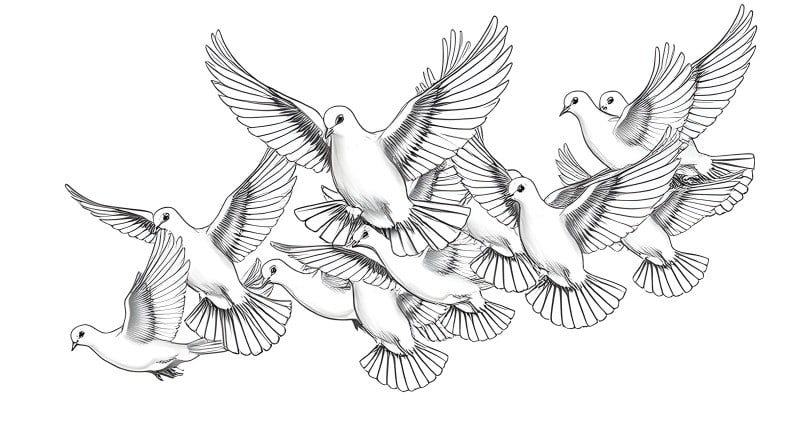Conoscere cosa accade in Turkmenistan può essere utile per immaginare la speranza a Gaza, Gerusalemme e Teheran. E capire perché il potere la teme.
Aşgabat dista oltre 2 mila chilometri da Gaza. Pur nella generale fascinazione per la geopolitica, il Turkmenistan non è il primo Paese che si penserebbe di collegare alla crisi umanitaria in corso in Palestina. Eppure le distanze si accorciano se si considera che il governo-tandem dei Berdimuhamedow, padre e figlio, si è mobilitato per contrastare quelli che vengono definiti “centri esteri di sabotaggio ideologico”, vale a dire i media indipendenti, che alimenterebbero le proteste popolari. La soluzione può far sorridere, ma solo se si vive lontano dal regime autoritario turkmeno: funzionari pubblici passeranno di casa in casa per raccogliere testimonianze su quanto sia bella la vita nel Paese. Registrando minuziosamente ogni reazione di dissenso.
La partita mondiale si è spostata sul controllo sociale. Accade in India, con il sistema di identificazione biometrica Aadhaar. Succede nel cosiddetto Occidente, che può forse vantare una maggiore democrazia ma anche sistemi di controllo della masse più raffinati. A tal proposito, se il palantír vi riporta soltanto all’universo immaginato da Tolkien, beati voi: la realtà della sorveglianza globale ha superato di gran lunga ogni più inquietante sfera di cristallo, negli Stati Uniti (e non solo), grazie a un colosso tecnologico specializzato in analisi dati e sorveglianza di massa che ha suscitato malumori anche fra i Repubblicani. Sempre negli States, suscita perplessità anche la reazione muscolare del presidente Donald Trump contro il dissenso verso i raid della Immigration and customs enforcement (Ice), che da mesi rastrella il Paese a caccia di migranti che si suppongono “irregolari” (e che non sempre lo sono, per quel che vale).
Il dissenso ha la forza di cambiare lo stato delle cose, e le forme oppressive del potere se ne sono accorte da tempo. Lo rende evidente una delle crisi più gravi – per complessità, durata e implicazioni – della nostra storia: il conflitto tra Israele e Gaza. Un elemento cruciale spesso trascurato nel dibattito politico e mediatico è il ruolo potenziale delle popolazioni civili, sia israeliana che palestinese, nel porre fine a questa spirale di sangue. Una mobilitazione popolare interna, un movimento di massa dal basso che rifiuti la logica della guerra e della vendetta, potrebbe rappresentare l’unico reale catalizzatore per una pace duratura.
Negli ultimi decenni, gli sforzi diplomatici internazionali – dagli Accordi di Oslo agli interventi delle Nazioni Unite, fino alle recenti mediazioni regionali – hanno fallito nel risolvere il conflitto in modo strutturale. I limiti delle soluzioni “dall’alto” stanno nell’asimmetria di potere fra Israele e le entità palestinesi, che mina l’equità nelle trattative, e nei forti condizionamenti geopolitici, nei quali gli interessi delle potenze regionali e globali spesso agiscono da freno a una soluzione equa; ma soprattutto nella polarizzazione interna, che punisce politicamente ogni apertura delle parti al compromesso.
La frammentazione politica che caratterizza entrambi i contesti – con la destra radicale israeliana in ascesa e la divisione tra Hamas e ANP nei territori palestinesi – soffoca ogni tentativo di immaginare altre possibilità. In questo quadro, le leadership in campo hanno poco incentivo a cambiare rotta. Le autorità politiche, costantemente legittimate o contestate attraverso la narrativa della sicurezza e della resistenza, hanno costruito il proprio consenso sulla perpetuazione del conflitto più che su una sua risoluzione. Lo stesso si può ben dire di Teheran, dove alla violenza degli attacchi israeliani corrisponde da decenni l’autoritarismo di un regime in cui la religione è strumentalizzata per la repressione di ogni contestazione.
In tutti questi contesti, la strutturazione di un energico fronte di dissenso popolare interno contribuirebbe a delegittimare lo storytelling dominante, che sia la narrativa securitaria israeliana, che ha reso quasi impossibile una riflessione collettiva sui costi umani, morali e politici dell’occupazione, oppure la retorica della resistenza armata come unico mezzo legittimo di difesa, predominante a Gaza, Cisgiordania e Iran.
Non si tratta di facile utopia. Dalla caduta dell’Apartheid in Sudafrica al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, fino alle rivoluzioni pacifiche dell’Europa dell’Est, sono stati i movimenti popolari, radicati nella società civile, a rovesciare sistemi apparentemente immutabili. Nel caso israelo-palestinese, se i contatti tra le due popolazioni sono ridotti al minimo, impediti da barriere fisiche e psicologiche, quando gruppi di attivisti israeliani e palestinesi hanno collaborato – come nei movimenti congiunti per i diritti umani o contro gli insediamenti illegali – si sono create le basi per una narrazione alternativa: quella della coesistenza. Una mobilitazione su larga scala rafforzerebbe queste reti, rendendole politicamente influenti e aprendo alla costruzione di spazi di cooperazione e solidarietà.
La pace non verrà raggiunta da capi di Stato – o da presunti attivisti – sotto i flash dei fotografi, fintantoché le rispettive popolazioni non saranno pronte a sostenerla e a difenderla. E tale maturazione non può essere imposta: deve sorgere dal dolore, ma anche dalla coscienza. Dalla consapevolezza che vivere nel conflitto perpetuo non è un destino, ma una scelta – e che esiste, seppur fragile, una via alternativa. Nel caso dell’Iran, le spinte popolari per un cambiamento di rotta sono complesse e multifacettate, e negli anni si sono manifestate attraverso movimenti sociali, aspirazioni democratiche e tensioni legate alla politica estera e alle sanzioni internazionali.
Il trauma collettivo, alimentato da decenni di sangue e lutti, rende difficile immaginare l’altro come interlocutore, invece che come nemico. Eppure, proprio per questo, una mobilitazione popolare sarebbe rivoluzionaria. Opporsi ai bombardamenti, all’ideologia, alla deumanizzazione dell’altro significa ridefinire il campo delle possibilità. Rompere il silenzio, l’indifferenza, il fatalismo è già un atto politico. La speranza è un atto politico e, insieme, di responsabilità. È sempre più urgente recuperarne il senso collettivo, ottuso da strategie di distrazione di massa. La storia è – e continuerà ad essere – piena di muri abbattuti a mani nude. Anche in Medio Oriente da tempo la chiave non risiede nelle stanze del potere, ma nelle strade, nelle piazze e nei cuori di chi ha scelto di smettere di odiare, nonostante tutto.
© Vuoi riprodurre integralmente un articolo? Scrivimi.
Sostieni Caffestoria.it